|
|

Copertina del mese di Maggio 2001
|

Maternità
Foto di Damiano Morandinii
|
Appressamento della morte
O Vergin Diva, se prosteso mai
Caddi in membrarti, a questo mondo basso,
Se mai ti dissi Madre e se t’amai,
Deh soccorri lo spirto lasso
Quando de l’ore udrà l’ultimo suono,
Deh tu m’aita ne l’orrendo passo.
|
|
|
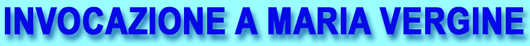
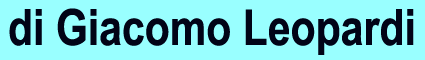 di Francesco di Ciaccia
di Francesco di Ciaccia
Giacomo Leopardi, un grande spirito davvero infelice, fu sempre in attesa della “madre”: quella dolcezza amorevole che mai ebbe in sorte di godere.
In una Cantica, egli si rivolge alla Vergine Madre: e lo fa con tutto il suo cuore.
Aveva diciotto anni soltanto: e già si prefigurava la fine. Persino da piccolo gli mancò la tenerezza materna: la madre, Adelaide Antici, si era dovuta accollare il compito di amministrare le terre pontificie affidate ai conti Leopardi, dopo che suo marito, Monaldo, ne era stato interdetto per la disastrosa situazione economica della sua gestione. Non era un furbastro, Monaldo: era un buono! E per di più era un uomo di lettere: i conti non sapeva farli bene! Fatto sta che Giacomo ebbe una madre “assente”: il problema umano di tutta la sua vita di pena. Per di più, la madre mostrò solo l’aspetto duro del proprio carattere. Il quadro che ne fece il figlio fa rizzare i capelli. Egli scrisse che, quando uno dei figli cadeva malato, ella si rallegrava: il paradiso avrebbe avuto un’anima in più; ma anche perché, precisava, c’era una bocca in meno da sfamare, in famiglia! Comunque, la madre non baciò mai un suo figlio: neppure quando era poppante.
Questo cenno era d’obbligo, semplicemente per cogliere la ragione, biografica e psicologica, di quel bisogno, pressante e drammatico, di Giacomo per la figura materna: sia essa la stessa Natura, sia essa la donna. Qui, in questa Cantica composta di getto, in undici giorni, tra il novembre e dicembre 1816, egli immagina, a imitazione dantesca, di compiere il viaggio nell’oltretomba. Si sente già morto:
ma forse mai nacque, alla vita. Però, come avviene nel poeta di Recanati per tutti gli aspetti della esistenza, proprio l' “assenza” dei beni più intimi e umani gli fa capire le profondità di ciò cui aspira il cuore dell’uomo, e che l’uomo non ha. Ed è poesia: la più sublime.
Nel paradiso, a cui approda il poeta a imitazione dantesca, egli si rivolge prima al “Padre”, definito anche “Re supremo” e “Creatore”, pregandolo di accoglierlo in cielo quando morirà. Ma ha paura: Dio è anche giudice. L’autore riconosce di non meritare il paradiso, anche se a propria discolpa osserva che, quando peccò, era per fragilità e non per malizia. A questo punto, ad ogni buon conto si rivolge alla Madonna. E le sue parole sono toccanti. Bisogna dire, è vero, che nel componimento il diciottenne Leopardi (ma aveva già scritto una caterva di opere, all’epoca!) mostra un forte retaggio dantesco: nel Paradiso, Dante, tramite san Bernardo, si rivolge alla Madonna. Ciò tuttavia non toglie che il poeta sia davvero sincero. Del resto, era il tempo in cui incominciava a sentire l’insofferenza per quella vita da collegio, chiusa e rigida: anche le passeggiate, di obbligo, erano svolte con l’istruttore di famiglia, e il poeta ne ha lasciato un gustoso ricordo nella poesia Lo scherzo. Ed era anche il tempo in cui incominciò a prefigurarsi la morte come unico, e felice, sbocco della sua travagliata esistenza. Proprio per questo motivo gli accenti dei versi sono toccanti. E autenticamente umani.
L’appellattivo di “Diva” riferito alla Madonna non stupisce: era tipico del linguaggio classicheggiante. Gli scrittori sacri lo usarono normalmente fino al Seicento ed oltre. Ma, nella prassi leopardiana, esso indica sempre una idealità. Lo si attribuiva, e lo stesso Leopardi lo fece dai primi agli ultimi Canti, alla donna amata: alla donna che rappresentava il massimo dell’aspirazione sentimentale. Egli si rivolge dunque a lei, come alla sua preferita, se così si può dire. E in effetti ricorda, per perorarne l’aiuto, che egli non cessò mai di ricordarla, per quanto si fosse adagiato, supino sulla miseria del mondo.
Non bisogna dedurne che Giacomo sia stato un gran peccatore: non è vero! Ma credo che l’autoaccusa fosse sincera: era canzonato da tutti, come egli stesso ricorda in tanti suoi scritti. Si sentiva una pezza da piedi: persino sua madre lo canzonava! Ed ecco, allora, il senso della maternità di Maria: a lei egli pensava come a una autentica madre. La madre della bontà! E ha una risonanza di squisita verità, quando egli rammenta di averla avuta nella mente, e di averla chiamata con le labbra, col dolce nome di Madre! Fino ad amarla.
Ed ora che ha la morte nella prefigurazione della fantasia, ha paura: ha paura del transito, del passo orrendo. Morire è sempre un dramma, e il pensiero della morte è doloroso. Lo è anche per chi è stanco, “lasso”, di vivere. Pochi versi prima aveva scritto: «E sento ‘1 cor che batte e sento un gelo / quando penso che s'appressa il punto estremo». L’unica sua speranza è riposta in Dio, come appunto ha scritto poco prima, e nella intercessione di Maria. Maria, dunque, veramente consolatrice degli afflitti!
Nel 1818, quindi a venti anni, quando ormai era profondamente in crisi circa i valori che aveva recepiti dal suo ambiente, il Leopardi progettò alcuni “Inni Cristiani”. In quel tempo, egli già constatava con amarezza e sconforto come i mali della vita terrena, pur essendo “brevi e nulli”, “riescono lunghissimi e insopportabili”, cioè sono sentiti interminabili e atroci. Giacomo già soffriva alla vista; e, se non aveva proprio la gobba, una malformazione alla colonna vertebrale era chiara. In effetti egli fa riferimento alle precarie condizioni di salute.
Allargando il discorso in generale, come era nella sua fervida mente, riconosce come noi esseri umani “siamo piccoli”, deboli, e a questo punto si rivolge supplice a Colei che è “grande e sicura”. Anche questo atteggiamento ha una lunga tradizione nella letteratura sacra e nella devozione popolare.
Giacomo Leopardi non ha dunque scoperto nulla di nuovo, circa il tema mariano; ha provato invece gli stessi sentimenti che tante persone, in tanti secoli, hanno sentito nei confronti della Madre di Dio e Madre della umanità: la Donna del perdono e della pietà. Se poi è vero che manca nel discorso leopardiano la portata morale della devozione, bisogna anche dire che le sue espressioni religiose erano, all’epoca, leali e sincere.
|
|
|
|



